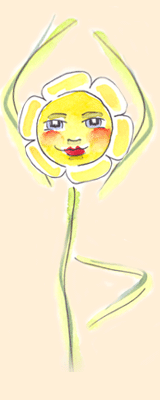È una donna minuta, ma il suo sguardo dapprima, e poi la sua voce non lasciano dubbi: Rebiya Kadeer è una donna d’acciaio. “Non c’è ostacolo che non si possa superare, non c’è traguardo che non si possa raggiungere”. Con queste parole il padre terminava il racconto della sua fiaba preferita prima della buona notte. E Rebiya Kadeer quelle parole le ha fatte sue. Del tutto. Di umili origini ha fatto prima la lavandaia, poi la venditrice di abiti ed è quindi diventata imprenditrice e miliardaria. Era diventata una regina, come lei stessa dice. Poi ha perso tutto. Oggi è la più nota dissidente della Cina. Si batte per la libertà del suo popolo, gli uiguri che vivono nel Turkestan orientale, dal 1955 formalmente provincia cinese dello Xinjiang. Una regione che equivale a circa cinque volte e mezzo l’Italia e che nei decenni ha conosciuto ripetutamente il giogo delle potenze straniere non solo per la sua eccezionale importanza strategica ma anche perché il suo territorio custodisce sterminate ricchezze: petrolio, oro, uranio, ferro oltre al più grande giacimento di carbone del mondo. Rebiya Kadeer lotta perché la sua gente non perda la propria identità, perché vengano riconosciuti i diritti umani e finisca la repressione ai danni degli uiguri. Ha dato vita a scuole dove i bambini potessero imparare la lingua iugura, ha aiutato le donne, le mamme e gli orfani. Alla fine degli anni novanta è stata messa in prigione ed è stata liberata dopo cinque anni di dura detenzione grazie ad un accordo con gli Stati Uniti. Rebiya Kadeer è ora venuta in Italia per presentare la sua storia raccontata in ‘La guerriera gentile. Una donna in lotta contro il regime cinese’ pubblicata da Corbaccio.
Il governo cinese aveva promesso di integrare il popolo uiguri e di dare sviluppo alla regione. Negli anni novanta lei stessa è stata il simbolo di questa trasformazione, era membro del Parlamento ed era una delle persone più ricche del paese. Cosa è successo dopo? «I cinesi parlano sempre del Turkestan orientale come della Provincia Autonoma Uigura dello Xinjiang, con una propria autodeterminazione. Ma questa non è la realtà. Ad esempio il governo cinese non permette al popolo uiguro di professare la propria religione, di parlare la propria lingua, non ci sono scuole dove i bambini possano imparare l’idioma dei genitori, se un padre insegna la propria fede musulmana al figlio rischia la prigione o addirittura di essere ucciso. Poco dopo l’invasione i possidenti terrieri musulmani di origini nobili vennero eliminati. I proprietari o i piccoli possidenti vennero invece derubati di tutte le loro proprietà, tra questi c’era mio padre. Da lui ho imparato a non abbattermi mai, che si può sempre ricominciare da zero. Ho lavorato e non mi sono risparmiata. Con quello che guadagnavo aiutavo il mio popolo, ho fondato scuole, assistito le donne, fino al mio famoso discorso al Congresso Nazionale a Pechino verso la fine degli anni novanta. Il discorso doveva essere consegnato per essere valutato e, se necessario, censurato. Io presentai un dattiloscritto falso. Volevo che i deputati cinesi fossero messi di fronte a ciò che stava accadendo nello Xinjiang. Tre mesi dopo fui sollevata da tutte le mie funzioni, i titoli, gli incarichi. Le mie attività commerciali furono bloccate e mi tolsero il passaporto.»
Eppure di lì a poco diede vita a Il movimento delle Mille Madri?
Nonostante i problemi personali ritenevo fosse essenziale continuare a battermi. Con la costruzione delle scuole e il sostegno ai bambini poveri non c’ero riuscita. Ero però convinta che il cambiamento potesse avvenire soltanto grazie alle madri. Le donne iugure dovevano avere fiducia in se stesse. Perciò decisi di renderle economicamente più forti. Le avrei aiutate a mettere in campo le loro forze. Fondammo il Movimento delle Mille Madri. Durante la festa di inaugurazione il numero di adesioni crebbe e crebbe. I giornalisti facevano riprese e interviste. Ma la sera non comparve nessuna notizia. Nel pomeriggio le redazioni avevano ricevuto l’ordine di non trasmettere nulla che riguardasse il nostro Movimento. La notizia di quel tentativo di soffocare la nostra voce divenne esplosiva. All’inizio eravamo solo donne iugure, poi si aggiunsero anche uzbeke, tartare, kazake, mongole. Creammo consultori in ambito sanitario e sociale. Le donne più anziane lo facevano come volontariato. Era la prima volta che accadeva una cosa simile.
Lei è madre di 11 figli, eppure non ha ceduto di un passo nella sua lotta per la difesa dei diritti del suo popolo. Quando ha deciso di allontanare da sé i più piccoli, mandandoli negli Stati Uniti dove già suo marito si era rifugiato come dissidente?
Era un peso grosso separarmi dai miei figli, ma ero sicura che in qualche modo li avrei raggiunti presto in America. Non potevano vivere con me, era ormai troppo rischioso e venivano continuamente controllati. Non era più una vita quella. Mio marito quando lo seppe sbottò: “Ma che razza di donna sei? Sembri una bomba. Hai squarciato la famiglia.” Ed anche i miei figli maggiori mi rimproverarono: “Hai mandato i nostri fratelli negli Stati Uniti … e tu sei rimasta qui. Senza l’amore di una madre, che razza di vita è la loro?” Io
ribattevo: “Gli Stati Uniti sono molto meglio che qui. E hanno il loro papà”. In cuor mio non vedevo l’ora di andarmene, di riuscire a riunire tutta la famiglia lontano da lì. Cercai anche una soluzione illegale. Ma mio marito mi sconsigliò. Pochi giorni dopo venni arrestata.”
E in prigione le vietarono di vedere i suoi figli rimasti con lei in Cina
Feci più di uno sciopero della fame. Chiedevo innanzitutto di vedere i miei figli. Solo dopo nove giorni del secondo sciopero della fame accettarono le mie condizioni. Le visite dei miei figli rappresentavano l’evento straordinario che rompeva la monotonia della mia vita. I nostri colloqui seguivano sempre il medesimo schema. Era vietato appoggiare le mani sulla parete di vetro e tenerle vicine. Anche sorridere ci era vietato. Dovevamo parlarci con la maggiore indifferenza possibile. Se le lacrime rigavano il volto dei miei figli, dall’altoparlante si sentiva dire: “Se piangete, la prossima volta non vedrete vostra madre.” Una volta mio figlio Kahar mi fece un cenno d’intesa, che venne ripreso dalla videocamera: non poté più incontrarmi per sei mesi.
Dopo quasi sei anni di carcere è stata liberata e ha potuto raggiungere suo marito negli Stati Uniti e nel 2006 gli uiguri in esilio l’hanno eletta presidente dell’Associazione Americana degli uiguri. Come vivono i suoi figli la sua condizione di rifugiata e la sua scelta di voce fuori dal coro?
Il giorno dopo la mia nomina i miei figli rimasti in Cina sono stati arrestati. Mentre ciò accadeva, tra i pianti e le urla, mi chiamarono al telefono. I poliziotti li avevano deliberatamente lasciati fare la telefonata perché dovevo sapere che erano nelle loro mani e che potevano far loro ciò che volevano. Pur in prigione e agli arresti domiciliari però continuano ad essere orgogliosi delle mie scelte e sono legati a me e alla nostra causa.
Quello dei bambini è un tema a lei caro. Ancora ogni anno bambini iuguri vengono allontanati dalle loro famiglie. Cosa accade loro?
I bambini, soprattutto dai 7 ai 16 anni, vengono portati in altre città molto lontane dal paese e villaggio d’origine, spesso a Pechino o Shangai, lontani dalle famiglie ma anche dalle loro abitudini e costumi. In città e scuole dove non possano sentire la loro lingua, dove non possano conoscere la loro storia, le loro tradizioni e il loro cibo. Ciò che fanno è un lavaggio del cervello alle nuove generazioni.
Ha mai pensato di scrivere un libro dedicato proprio alle nuove
generazioni per parlare loro degli uiguri?
Uno dei miei sogni è di scrivere un libro di favole in lingua iugura. Un libro dedicato ai bambini perché non dimentichino la ricca letteratura del nostro popolo.
A cura di Laura Ogna
www.forkids.it